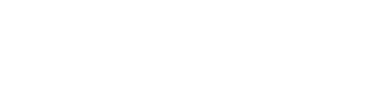Dal 2020, le Portinerie di Comunità rappresentano un punto di riferimento per il territorio, offrendo servizi di prossimità e costruendo reti sociali che rafforzano il senso di comunità. Ideate dalla Rete Italiana di Cultura Popolare, queste realtà nascono a Torino e si sono estese ad altre aree interne, come Pont Canavese, grazie alla collaborazione con enti locali e al sostegno strategico di Fondazione CRT. Le Portinerie si distinguono per il loro duplice ruolo: da un lato, fungono da centri operativi per piccoli servizi quotidiani, come la consegna di pacchi o la ricerca di artigiani; dall’altro, agiscono come catalizzatori di relazioni, mappando i bisogni della comunità e attivando risposte condivise attraverso la collaborazione tra cittadini e attori locali.
“Fiducia, apertura, accoglienza, ascolto, risolutività. Una finestra aperta su quartieri e comuni” sono tra i valori che Camilla Munno associa alle Portinerie per raccontarle a chi ancora non le conosce. Responsabile della Rete nazionale delle Portinerie di Comunità, Camilla segue la progettazione culturale e coordinamento di progetti complessi con un occhio sempre attento alla comunicazione delle attività.
Per conoscere questo mondo più da vicino, le abbiamo fatto qualche domanda:
Come hai iniziato a collaborare con la Rete delle Portinerie di Comunità?
Ho iniziato nel 2020, proprio quando stava aprendo la prima Portineria a Porta Palazzo. Venivo da un’esperienza accademica negli studi urbani e mi sono avvicinata alla Rete attraverso un progetto di comunicazione visual per il Festival delle Piccole Storie. Poi, quell’estate, c’era bisogno di una “portinaia” e mi sono messa in gioco: ho iniziato a gestire lo spazio, ascoltare le persone e costruire comunità. Da lì, ho seguito le coprogettazioni, attivato servizi di prossimità e contribuito all’animazione della piazza con eventi come il Cinema di Portineria, serate musicali e presentazioni di libri.
Quante persone lavorano per le Portinerie e com’è una tua giornata tipo?
Siamo circa una ventina, distribuiti tra Piemonte, Lombardia, Sicilia e altre regioni. La mia giornata si svolge principalmente al Fondo Tullio De Mauro, la sede della Rete, che ospita anche la Biblioteca dialettale tutelata dal MIC. È un luogo dinamico, sempre aperto a incontri, rassegne, coworking e prove teatrali. Il mio tempo si divide tra riunioni di coordinamento, call con partner, allineamenti con le diverse Portinerie e la scrittura di nuovi progetti.
Come sono cresciute in questi quasi cinque anni di attività?
Hanno fatto un percorso di crescita incredibile: si sono strutturate, adattandosi alle specificità dei territori in cui operano. Hanno modellizzato le loro buone pratiche, riconosciute come best practice dall’European Social Fund, e creato infrastrutture sociali in grado di evolversi nel tempo. Il modello si è poi trasformato in un social franchising, uno dei pochi in Europa, rendendo le Portinerie replicabili e scalabili in nuove città.
Quali sono i servizi più richiesti e come cambiano a seconda del quartiere?
Le Portinerie variano molto in base ai bisogni locali. A Porta Palazzo, ad esempio, sono richieste pratiche per persone straniere, assistenza per la scrittura di CV, doposcuola gratuito e piccole commissioni. A Borgo San Paolo, invece, il bisogno principale è la socialità: le persone cercano soprattutto spazi di incontro. Nel Canavese, oltre ai servizi digitali e di assistenza domiciliare, stanno avendo grande successo i gruppi di uncinetto, che coinvolgono generazioni diverse.
Qual è stato il servizio più insolito che avete offerto?
Durante il lockdown, abbiamo gestito situazioni incredibili, come ricevere e consegnare poltrone, stoccandole in un’edicola di soli 10 mq. Attività come questa continuano ancora oggi su piccola scala, ma in quel periodo avevano un significato completamente diverso. Rispondevamo alle richieste degli abitanti, portando a domicilio fiori, cappuccini, libri desiderati, caffè o legumi sfusi, tutto ciò che si poteva acquistare nei negozi di prossimità.
Tra le iniziative più belle, abbiamo creato sacche in stoffa per mamme e bambini, coinvolgendo un gruppo sartoriale di donne provenienti da Bangladesh, Marocco, Egitto e Somalia. Da lì, ne sono nate molte altre: la consegna di fiori e cioccolatini agli innamorati, il pane distribuito in tutta la città, fino alla nascita della Scuola delle Portinerie, che ha trasformato le attività commerciali del quartiere in spazi dedicati alla lettura, allo studio e persino all’apprendimento del cinese.
Uno dei miei progetti preferiti è stato il bike sharing di Portineria: dalle biciclette donate nei cortili di Porta Palazzo, abbiamo creato un vero punto di condivisione, coprogettato con il quartiere. Oggi permette di spostarsi da una Portineria all’altra della città e stiamo lavorando per replicarlo anche in altre aree più interne.
Ci racconti qualche storia a cui sei particolarmente affezionata?
Sono particolarmente legata alla storia della Comunità del Dono, un progetto semplice ma ambizioso nato nel 2020 insieme alle famiglie dell’Ex Moi e alle tante associazioni che le supportavano. Con CTRL Community e Refugees Welcome, abbiamo iniziato raccogliendo le letterine di Natale di bambine e bambini provenienti da contesti fragili. Dai loro desideri è partita una raccolta fondi che, in soli 15 giorni, ha superato i 6.000 euro, permettendoci di realizzare tutti i regali.
Ma non ci siamo fermati lì: entrando in punta di piedi nelle storie di ciascuna famiglia, abbiamo attivato cure dentistiche gratuite, donato letti e frigoriferi, organizzato lezioni di pittura, supportato pratiche burocratiche, creato gruppi di conversazione, doposcuola e persino gite al museo. Donatori e donatrici non hanno contribuito solo economicamente, ma anche con il loro tempo e le loro competenze.
Oggi la Comunità del Dono è cresciuta: dispone di un fondo di oltre 10.000 euro, supporta 300 nuclei familiari e può contare su una rete di oltre 200 donatori attivi.
Hai avuto momenti in cui hai sentito che il tuo lavoro stava facendo davvero la differenza?
Mi capita spesso di pensarci. Ogni volta che una domanda trova risposta in un sorriso – perché siamo riusciti a risolvere una pratica complessa, a iscrivere una bambina a scuola, a inserirla in un doposcuola, o a mettere in contatto qualcuno con il Centro per l’impiego – sento che abbiamo fatto qualcosa di davvero utile.
Ma c’è anche un altro aspetto fondamentale: la partecipazione culturale. Far incontrare persone di ogni fascia sociale attorno a una passione comune, che sia la cucina, il cucito o lo scambio linguistico, è una delle sfide più grandi, ma anche la più gratificante.
Quali sono le sfide più grandi per le Portinerie oggi?
Le sfide riguardano in parte il sistema del terzo settore, che sta attraversando un grande cambiamento. È fondamentale che riesca a valorizzare il proprio ruolo sussidiario e collaborativo con l’ente pubblico, senza perdere di vista la responsabilità di tutelare il know-how e le idee, costruire relazioni e non limitarsi all’erogazione di servizi.
A dire il vero, la parola servizi non mi piace molto. Preferisco parlare di opportunità e occasioni, risposte che nascono dalla collaborazione tra diversi attori e da un approccio multilaterale, capace di creare un ecosistema in cui ognuno contribuisce in modo attivo.
Le Portinerie si basano molto sulla fiducia e sulle relazioni. Come si costruisce la fiducia con la comunità locale?
Sì, le Portinerie si basano sulla costruzione di relazioni e sulla fiducia. Si parte dalle piccole cose: affidare le chiavi di casa, prendersi cura di gatti, cani, pesciolini o piante. Gesti semplici, ma di grande responsabilità, che rappresentano un segno concreto di fiducia.
Su scala più ampia, questa fiducia diventa il motore della collaborazione tra enti del terzo settore, aziende, scuole ed enti pubblici. L’obiettivo è costruire un sistema che funzioni come un’infrastruttura di supporto per la persona, nelle sue diverse sfaccettature.
A tutto questo si aggiunge un elemento fondamentale: la creatività. È ciò che rende il nostro lavoro più bello e stimolante, permettendoci di trovare soluzioni innovative, inedite e su misura per affrontare gli imprevisti.
In che modo le Portinerie si integrano con i servizi pubblici?
La Rete delle Portinerie, insieme al social franchising, include un accordo specifico con gli enti pubblici per favorire l’integrazione con i servizi istituzionali. Un esempio concreto è la collaborazione con l’Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l’impiego, che ogni 15 giorni sono presenti in una delle Portinerie, offrendo orientamento lavorativo ad adulti, studentesse e studenti.
Un altro tassello importante è il protocollo INPS per tutti, che aiuta a intercettare bisogni inespressi e a guidare le persone nella richiesta di misure di sostegno. A questo si aggiunge il rapporto con gli uffici pubblici delle città in cui operiamo, occupandoci di tematiche che spaziano dal supporto agli adulti in difficoltà ai servizi per stranieri, dall’anagrafe alla gestione dei beni comuni e del suolo pubblico.
Nel Canavese, invece, siamo stati coinvolti dal Consorzio socio-assistenziale CISS38 per costruire una governance territoriale su 26 comuni, iniziando con una mappatura dei servizi attivi e del loro funzionamento. Questo lavoro si sta sviluppando ulteriormente attraverso il progetto CARE, un’iniziativa transfrontaliera della Città Metropolitana di Torino, che ci vede impegnati con altri consorzi per applicare il modello delle Portinerie in alcune valli piemontesi.
Il nostro approccio si sta espandendo anche nel Sud Italia: a Palermo, in collaborazione con il Comune, e ad Agrigento, dove stiamo lavorando per adattare il modello alle esigenze del territorio.
Dove vedi le Portinerie tra cinque anni?
Tra cinque anni immagino una rete di Portinerie vitale e autonoma, diffusa in tutta Italia. Ogni Portineria diversa, radicata nel proprio contesto, ma parte di un’unica rete nazionale capace di connettere aree urbane, periurbane e interne. Un sistema in grado di collaborare con enti pubblici, privati e aziende, trasformando le dinamiche territoriali e politiche, generando risposte concrete e creando spazi di incontro gratuiti e accessibili a tutti.
Ma il mio sguardo va oltre i confini nazionali. Mi piacerebbe vedere le Portinerie replicate in Europa, adattate a nuovi contesti: teatri, conservatori, fattorie, mulini di piccoli e grandi centri. Immagino luoghi trasformati da questo modello, arricchiti dal valore unico che ogni comunità di prossimità può offrire, contribuendo a farlo crescere e evolvere nel tempo.
Ci sono dei momenti o delle persone che ti hanno ispirato particolarmente in questo percorso?
Mi ispirano la nostra Presidente, Chiara Saraceno, e il direttore Antonio Damasco, che con grande eticità e ingegno guidano il nostro lavoro. Ma l’ispirazione arriva anche dalle tante persone che ho avuto la fortuna di incontrare nelle rassegne culturali, nelle Summer School e nei Festival della Rete: figure come Gustavo Zagrebelsky, Franco Lorenzoni, Gianenrico Rusconi, Linda Laura Sabbadini, Tullia Todros, e poi Ambrogio Sparagna, Enzo Moscato, studiosi, antropologi, sociologi, artiste e artisti.
La Rete tiene insieme tanti pezzi, ma soprattutto tante persone. Quelle che incontro ogni giorno nelle Portinerie: le mamme sole che lavorano con quattro figli, le famiglie di Indovina chi viene a cena?, le persone senza fissa dimora che qui hanno trovato un punto di riferimento e che ci donano le loro storie e la loro umanità. Sono loro, più di tutto, a dare senso a ciò che facciamo.
Che consiglio daresti a chi vuole avviare una Portineria?
Il mio consiglio è di studiare, prepararsi e fare ricerca, perché è la base del nostro lavoro. Oltre a questo, è fondamentale costruire una struttura organizzativa solida e garantire una sostenibilità a medio termine, elementi essenziali per entrare a far parte di questa rete nazionale.
Mi ispirano molti libri e mi piace spaziare dall’antropologia alla fotografia, dalla sociologia all’architettura, fino all’arte e al teatro. Leggo tantissimo e mi sorprendo sempre di quanto ci sia da imparare. Mi affascinano testi come Architettura di sopravvivenza di Yona Friedman, Progettare il disordine di Richard Sennett e Pablo Sendra, Third Place di Ray Oldenburg, La psicologia delle folle di Gustave Le Bon e gli scritti di autori come Byung-Chul Han, Marcel Mauss, Jurij Lotman, Norberto Bobbio, Eugenio Borgna, Susan Sontag, Jorge Luis Borges, Roland Barthes, Antonin Artaud e Bertolt Brecht. Mi lascio ispirare anche dalla letteratura di Simone Weil, Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Cesare Pavese, Primo Levi, Goliarda Sapienza e Banana Yoshimoto.
Credo che leggere di tutto e avere un approccio eclettico sia il modo migliore per ampliare la visione del mondo, perché ogni disciplina può offrire spunti inaspettati e far emergere connessioni che altrimenti non si vedrebbero. Anche la musica è una fonte di ispirazione continua. Amo ascoltare sonorità diverse, lasciarmi influenzare da ritmi e culture lontane. Mi piacciono molto i Baustelle, ma anche Bruce Springsteen, Billie Holiday, Luigi Tenco, Fabrizio De André e Lucio Dalla, senza dimenticare il reggae e il blues, che portano con sé una profondità espressiva unica.
Il cinema per me è uno strumento di comprensione della realtà e guardo molti film in lingua originale con sottotitoli, non per un vezzo, ma perché offre un’altra prospettiva da cui osservare il mondo. L’ultimo che ho visto è stato No Other Land, un documentario intenso e necessario.
Anche i podcast sono una parte fondamentale del mio quotidiano. Ascolto Il Mondo di Internazionale, per capire dove siamo posizionati nel contesto globale, e Actually di Will Media, per seguire le innovazioni e le trasformazioni sociali. Credo che essere curiosi e aperti a stimoli diversi sia il miglior modo per arricchire il proprio sguardo e trovare nuove chiavi di lettura per interpretare il presente.
- Vai al sito delle Portinerie di Comunità
Photo credits Laura Cantarella